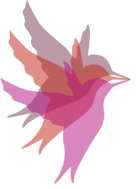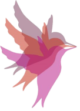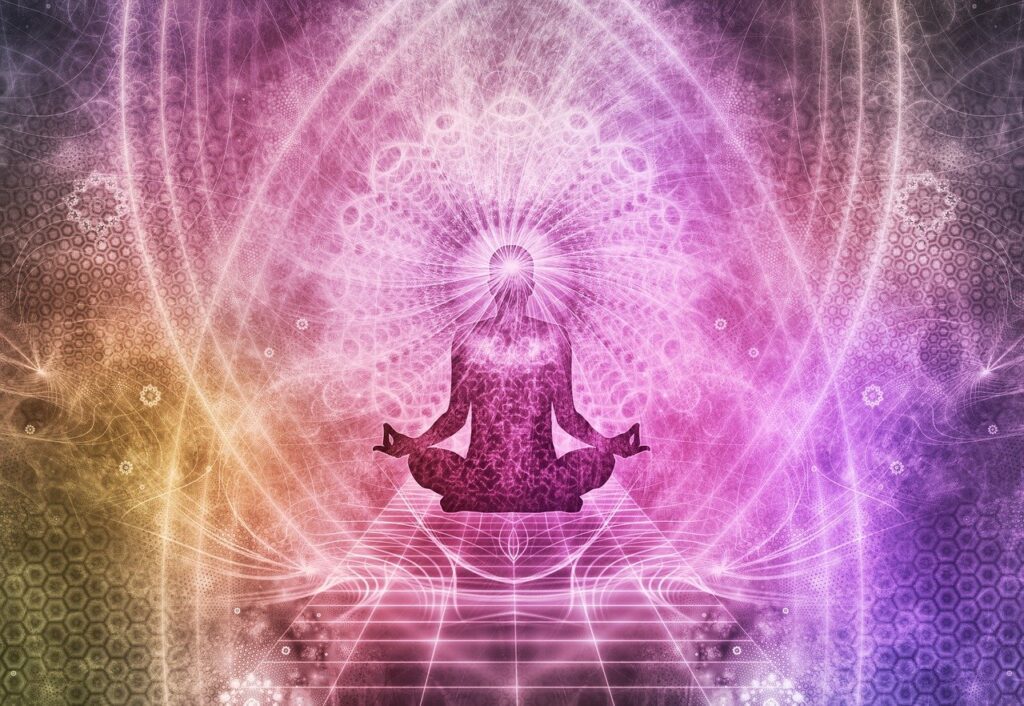di Cristina Contardi
La parola yoga è oggi conosciuta da molti, in diverse parti del mondo, ma non sempre è chiaro il suo significato e cosa realmente identifica, se una disciplina, una religione o una filosofia. La definizione che meglio la contraddistingue è quella di una pratica millenaria evolutasi attraverso differenti tradizioni che si sono integrate nel corso del tempo.
Oggi lo yoga ha raggiunto una tale popolarità da trasformarsi in un fenomeno di costume globale, spesso viene utilizzato per pubblicizzare dei prodotti trasmettendo un messaggio più mondano che interiore e viene anche associato a delle pratiche che non sempre aderiscono alla sua autenticità. Le interpretazioni che ne vengono date sono molteplici e nella accezione più moderna ha assunto una connotazione quasi unicamente fisica, dove l’importanza data alle innumerevoli āsana spesso non lascia spazio a quello che viene definito antaraṅga yoga, lo yoga interno. Questo aspetto, che tocca vari stati di coscienza, non è sempre facilmente attuabile in una società come la nostra dedita all’aspetto fisico-motorio del corpo e alla performance dove anche lo yoga si è, in diverse sue versioni, trasformato in uno sport e le posture fisiche, a volte complesse, sono diventate l’obbiettivo da raggiungere per migliorare sé stessi.
È importante ricordare che nei testi tradizionali il riferimento alle āsana è pressoché inesistente e, se presente, è relativo a posizioni sedute, comode e volte al raggiungimento di uno stato meditativo, tutto il contrario di ciò che viene proposto nello yoga cosiddetto moderno.
Negli Yogasūtra di Patañjali, uno dei testi fondamentali della tradizione vedica, non viene proposta alcuna posizione, ma aforismi che ci invitano ad indagare la coscienza attraverso percorsi pratici volti alla liberazione. Lo yoga si compone di una serie di pratiche e tecniche che ci guidano verso l’esperienza del nostro essere, verso le varie dimensioni e manifestazioni della coscienza, verso un divenire esistenziale in continua evoluzione. Nella tradizione non si parla di un solo corpo, bensì di cinque involucri, i kośa, di cui il corpo fisico è quello più denso nella sua manifestazione, ma esiste anche un “corpo energetico”, un “corpo di impulsi mentali”, un “corpo di conoscenza o intuito generato dalla mente superiore”, tutti avviluppati dal “corpo di beatitudine e gioia” ( 1 ). Il corpo fisico pertanto non è altro che la manifestazione grossolana di energie universali più sottili. Lo yoga invita ad utilizzare sempre l’esperienza sensoriale diretta, è una via esperienziale e “ascoltare” il proprio corpo è la prima fase per una pratica. L’āsana non è che un mezzo per poter fare questa esperienza di ascolto del proprio corpo e delle sensazioni che emergono ed è una via educativa alla non violenza, al non nuocere secondo i principi, gli yama e nyama, descritti negli Yogasūtra.
Secondo Mircea Eliade il significato del termine yoga “etimologicamente …deriva dal termine yuj legare insieme, tenere stretto, aggiogare…il vocabolo yoga serve in generale a indicare ogni tecnica d’ascesi e ogni metodo di meditazione. È il termine stesso di yoga che ha permesso questa grande varietà di significati: se infatti yuj etimologicamente vuol dire legame, è tuttavia evidente che il legame, cui questa azione di legare deve condurre, presuppone come condizione preliminare, la rottura dei legami che uniscono lo spirito del mondo. In altri termini la liberazione non può avvenire se non ci siamo innanzitutto staccati dal mondo, se non abbiamo già iniziato a sottrarci al circuito cosmico…nel significato di unione, lo yoga implica il distacco preliminare dalla materia, l’emancipazione dal mondo ( 2 ). Questa forma di distacco la si incontra nelle tradizioni più antiche dei Veda, delle prime Upàniṣad, degli Yogasūtra, del Sāṃkhya-kārikā, ma è un distacco in chiave evolutiva, volto ad affrancarsi da ogni tipo di sofferenza. L’unico modo per dissolvere la sofferenza è separando lo spirito dalla materia. Dal momento che il processo della trasformazione della materia risulta difficile e doloroso mentre lo spirito, immutabile, non può essere toccato dalla sofferenza, il praticante di yoga è invitato a riconoscersi in un’entità spirituale, eliminando quei blocchi che gli impediscono di vedere questo riconoscimento.
Nella pratica la cosa può essere sperimentata attraverso il distacco, l’allontanamento dai propri schemi posturali spesso dominanti per riappropriarsi di schemi più armonici, completi, funzionali, stabilendo nuove possibili unioni.

L’uomo non solo cerca di allontanarsi dal dolore e da ciò che può generare sofferenza, ma risponde anche ad una forza creativa, legata al desiderio, al piacere, all’espressione della propria potenzialità. Ed è proprio la via tantrica che troviamo nei testi quali l’Haṭhayogapradīpikā, la Gheraṇḍa-saṃhitā, il Vijñānabhairava che ci invita a unioni armoniche e piacevoli nei confronti della realtà e dell’universo nel suo insieme; è attraverso la visione del tantra infatti che la coscienza impara ad accogliere la vita, a sentirsi parte di essa, a sentire che è parte di un flusso vitale senza confini, sperimentando stati di felicità e completa aderenza alla realtà di cui fa parte e di cui è pervasa.
Unione e distacco, tradizione tantrica e vedica si integrano nell’esperienza della pratica yogica.
“Il significato di Yoga inteso come distacco, sacrificio, controllo sensoriale, si integrò col significato del termine inteso nel suo senso letterale: unione, cioè connessione con tutto ciò che può condurre, non solo alla liberazione, ma alla beatitudine e alla gioia, per sfociare in uno stato di stupore ed estasi che coinvolga il praticante in un abbraccio cosmico con il divino” ( 3 ) Nel tantrismo l’unione è anche identificazione con le forze cosmiche, divine della natura, un’identificazione che porta il nostro corpo ad essere percepito come natura, terra, aria, acqua, sole, spazio perché diventa esso stesso tali elementi. Allora, attraverso un atteggiamento ricettivo e di ascolto, potrò percepire nel mio essere la stabilità propria della terra, il movimento ondulatorio dell’acqua o il calore del fuoco e integrare così le caratteristiche di questi elementi. L’insegnamento portato in occidente da Jean Klein, che proviene direttamente dal Trika tradizionale del Kashmir, pone l’accento sulla bellezza, sulla libertà lasciata alla percezione e al suo assorbimento o sullo sviluppo illimitato delle percezioni corporee.

Il corpo, libero da ogni attività, è presenza e attraverso un ascolto privo di aspettativa abbandona la sua solidità e pesantezza ai punti di contatto con il suolo che rivelano un inaspettato risveglio sensoriale ed è in questa attenzione che la corporeità si trasforma in un vulcano di attività.
Solo quando si è percepito il corpo, con le sue sofferenze e i suoi impedimenti, si mettono in atto gli strumenti per purificarlo e armonizzarlo. Allora le posture diventano utili per migliorare l’efficienza corporea, creare delle connessioni e dei passaggi affinché i flussi respiratori e vitali possano scorrere agevolmente e raggiungere zone sopite, addormentate e risvegliarle, riportandole in vita. Abhinavigupta, maestro dello Shivaismo tantrico, ci ricorda che “la parte di felicità che si trova in ogni piacere della vita quotidiana è presa di coscienza del proprio sé” (P.29)
Cristina Contardi
Note
1. Dr Swami Gitananda Giri, Haṭha-yoga, Ed. Lakṣmī
2. Eliade M., Lo Yoga, Bur saggi, Milano p.20
3. Fioravanti G., Lo Yoga e le sue origini, p.34
Bibliografia
1 – Dr Swami Gitananda Giri, Haṭha-yoga, Ed. Lakṣmī
2 – Eliade M., Lo Yoga, Bur saggi, Milano p.20
3 – Fioravanti G., Lo Yoga e le sue origini, p.34
4 – Baret E., Yoga Tantrico – Asana e Pranayama del Kashmir, Roma