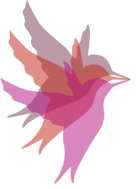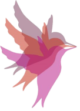Dott.ssa Daniela Braghieri – Dott. Angelo Granata
Scrivere un articolo che tratti dell’Omeopatia si è rivelato un poco più impegnativo di quanto non avessimo supposto. Il materiale non mancava, dal momento che avevamo alle spalle anni di lezioni preparate e tenute, conferenze e soprattutto lo studio della materia.
Al fine di fornire dei dati che, soprattutto a chi non la conosce, consentano di ricevere informazioni utili alla sua comprensione abbiamo scelto di pubblicare più paragrafi:
Le origini storiche dell’omeopatia.
Cristian Frederich Samuel Hahnemann – La vita e la sua intuizione
Fondamenti e metodologia
Diffusione dell’omeopatia
Par. I – Le origini storiche dell’Omeopatia
Conoscere le origini dell’Omeopatia, è fondamentale per comprendere quali passaggi evolutivi hanno permesso di arrivare a introdurre questo tipo di approccio al paziente, che non interferisce e non è incoerente con l’approccio tradizionale. Abbiamo un valore aggiunto che deve però essere impiegato correttamente.
Nei tempi antichi il malato era un peso tale da essere spesso allontanato dalla comunità a cui apparteneva e poteva solo sperare che i rimedi conosciuti potessero guarire le sue sofferenze o quantomeno alleviarle. A volte, tuttavia, qualcuno aveva un’illuminazione riguardo a eventuali soluzioni per curare delle malattie e si occupava così della salute delle persone.
I più importanti scritti risalgono alla medicina egizia (2700 a.C.). le cui pratiche erano supportate da numerose credenze religiose.
Nel XVII secolo a.C., in Mesopotamia, fu il codice di Hammurabi la prima testimonianza di un codice etico comportamentale. In alcuni capitoli troviamo un codice medico con eventuali pene qualora non fossero state rispettate le norme stabilite: il rapporto, dunque, tra curante e curato cominciava a essere tutelato. La sfera era comunque quella del misticismo e del soprannaturale, dal momento che erano i sacerdoti a praticare la medicina.
Nella Magna Grecia filosofi e ricercatori alimentarono la ricerca su alcuni aspetti dell’essere umano in particolare sulla differenza tra armonia e disarmonia. L’allineamento e l’equilibrio delle varie funzioni del corpo umano portavano ad uno stato di armonia, viceversa disallineamento e disequilibrio necessitavano di comprendere come si sarebbe potuto restituire lo stato di benessere perso.
Nel V secolo a.C., Empedocle ebbe un’illuminazione e affermò che il corpo era composto da 4 elementi fondamentali: fuoco, aria, acqua, terra, che nei giusti rapporti tra loro gli fornivano vitalità.
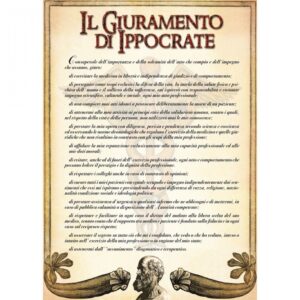
Egli fu l’ispiratore di Ippocrate (460 a.c.), uno dei padri della medicina che intuì che alcune armonie e disarmonie non derivavano solo dalla rottura dell’equilibrio di quelle 4 componenti fondamentali, intuite da Empedocle, ma anche come, lo stato di equilibrio dell’organismo. fosse correlato a come fossero in rapporto tra loro. Ippocrate aveva classificato i vari soggetti a seconda dell’umore prevalente e iniziò a definire e a descrivere le localizzazioni fisiche di situazioni che erano correlate a stati emotivi. Grazie a questa sua intuizione si iniziò a porre l’attenzione sugli aspetti psico-somatici dell’individuo. L’osservazione del paziente e dei suoi sintomi consentì di formulare una diagnosi in cui venissero considerati i fattori eziologici e causali. (1)
Fu il primo che ritenne di poter applicare la teoria della similitudine similia similibus curentur (i simili siano curati dai simili) che appunto si basava sull’osservazione. Quando un malato presentava dei sintomi simili a quelli che potevano essere indotti in una persona sana dalla somministrazione di dosi massicce ad esempio di una pianta, la stessa somministrata a piccole dosi riportava l’equilibrio perduto. Notò che la pianta dell’Helleborus induceva, se assunta ad alti dosaggi nel soggetto sano, una dissenteria ematica, mentre sotto forma di infuso a bassi dosaggi, curava certe dissenterie o gastroenteriti. Quindi deduce che è possibile ottenere delle guarigioni utilizzando, per curare le varie patologie, dei rimedi ottenuti da sostanze di specie diversa che, ad alti dosaggi, provocano gli stessi sintomi della patologia che desideriamo curare.
Questa è la motivazione che fa risalire a Ippocrate l’origine di uno dei concetti fondamentali dell’omeopatia: la teoria dei simili.
Con Ippocrate prende forma la metodologia empirica e razionale basata sul, vedere, constatare e annotare. Nascono coì le prime “banche dati” relative ai rimedi che via via vengono testati.
Prima di entrare nel vivo nella storia dell’Omeopatia e del suo ideatore, Hahnemann, vale la pena di fare una rapida carrellata lungo il periodo che seguì ad Ippocrate.
Le divergenze di opinione non tardarono e Galeno (129) medico greco sottolineò che “contraria contrariis curantur” (i contrari curano i contrari) in molteplici casi avrebbe costituito l’intervento più corretta. Di fatto questa affermazione è alla base dell’approccio allopatico che caratterizza ancora gli interventi medici sulle manifestazioni patologiche.
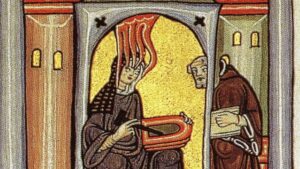
Prima del medioevo molti testi di fitoterapia e di medicina furono conservati nei monasteri.
Nel 1098 in Germania nasceva Ildegarda di Bingen, badessa, che scrisse il primo grande libro di fitoterapia in cui venivano elencate alcune patologie con cause e piante che potessero curarle.
Fu Federico II di Svevia (1194- 1250) sancì che per poter esercitare l’arte medica si dovessero fare corsi con conseguente esame di abilitazione alla professione.
I primi ospedali cominciano a sorgere Intorno al XII secolo e i primi passi avanti nella sanità presero forma con la nascita della figura del medico pubblico e in tutta Europa si aprirono facoltà di medicina. Sempre in quel periodo nacque anche la figura del chirurgo. Ne conseguì una dicotomia tra il medico che osservava e quello che operava e le malattie cominciarono ad essere catalogate per competenza. I chirurghi venivano aiutati dai barbieri che possedevano le lame più affilate e comunque dovevano dimostrare di essere in grado di crearsi gli strumenti con cui avrebbero operato.
Fu intorno al 1500 che Andrea Vasalio uno dei più grandi anatomici, scrisse il primo volume di anatomia umana e Gerolamo Fracastoro umanista, che si occupò anche di medicina, intuì che dietro alla sifilide potesse esserci qualcosa di invisibile che poteva essere trasmesso da un corpo all’altro e pose così le basi della moderna batteriologia.
In quel periodo Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, detto Paracelso, medico e alchimista svizzero, evidenziò e sostenne che i pazienti erano i libri dei medici e che andavano considerate proprie le differenze tra un paziente e l’altro cercando anche di comprendere come il sintomo fosse arrivato a manifestarsi nel paziente. Sottolineò, riprendendo Ippocrate, che il rimedio che viene impiegato in medicina è uno strumento che può dare la vita o la morte a seconda di come viene usato con particolare attenzione alle formulazioni e a come poi sarebbero state impiegate.
Nel 1600. Malpighi, biologo e medico Bolognese si fece dare dal suo maestro Galileo delle lenti che iniziò ad usare per studiare il corpo umano. Mentre il microscopio entrava ad ampliare gli orizzonti della medicina e a scoprire come fosse costituito il corpo umano nelle sue componenti invisibili ad occhio nudo i medici condotti avevano fatto loro il motto curare pauperes et miserabiles sine mercede (curare i poveri e i miserabili senza compenso).

Nelle università si continuava ad insegnare la teoria di Galeno basata sui quattro umori e i principali metodi di cura consistevano in salassi e purghe a dosi generose che venivano prescritti per promuovere il riequilibrio del corpo e questi insegnamenti continuarono ad essere trasmessi sino al 1800.
In questa realtà nel 1755 nasce Hahnemann che diventerà il padre dell’Omeopatia.
Fine primo paragrafo
a ottobre il secondo paragrafo: Cristian Frederich Samuel Hahnemann – La vita e la sua intuizione
Dott.ssa Daniela Braghieri – Dott. Angelo Granata
Note:
1. La parola “eziologia” significa “discorso sulla causa”. Per comprendere la differenza tra fattori eziologici e causali facciamo un esempio. Una persona si trova in una situazione di freddo, è poco coperta. Il freddo penetra nel corpo e la persona sviluppa una bronchite. Il freddo è la causa immediata, il fattore causale. Esiste però una causa a monte, ad esempio questa persona sta passando un periodo di intenso lavoro, poco riposo e molta tensione nervosa. Questo fatto è ciò che ha predisposto il corpo a far penetrare il freddo e reagire con una malattia. Questa causa sottostante è il fattore eziologico.